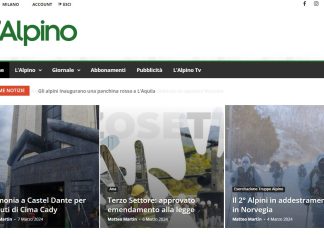Il cuore palpitante, la mente vuota e inebetita, la canna di una pistola russa puntata. Il tamburo gira lentamente, uno scatto sordo e un attimo che dura un’eternità. “Clic”, a vuoto… E se i tedeschi da giustiziare fossero stati di meno? E se l’ultimo per morire non avesse dovuto essere colpito da più di un proiettile? L’attimo tra la vita e la morte è come una raffica di vento sferzata dal caso.
«Davài! Avanti!», vivo e nuovamente in colonna, il sottotenente Carlo Vicentini ritornava con gli altri Alpini, in attesa di sapere quale paradiso era stato scelto per lui. «Signor tenente, gli ufficiali son quelli che rischiano di più, si tolga i gradi!», lo esortavano alcuni. Ma lui nulla. In fondo era prigioniero dei russi e nessuno gli imponeva di doverli tenere, se non la sua dignità e il rispetto per il ruolo che aveva e per i suoi uomini.
Incolonnati, marciavano in un paesaggio desolante e spettrale: «La neve viaggiava di traverso, quasi orizzontale, a velocità vertiginosa e trafiggeva la faccia, entrava negli occhi, scendeva nei polmoni». Mangiavano ogni tre giorni una pagnotta nera e molliccia, una ogni dieci uomini. Dormivano dove capitava, nelle chiese diroccate o sul gelido selciato delle piazze e coloro che si stendevano un attimo a riposare venivano colti dal sonno eterno. In breve tempo, nonostante gli sforzi per rimanere accanto ai compagni di reparto, il destino di ciascuno seguì una diversa, imprevedibile sorte.
Dopo un anno i prigionieri furono trasferiti nel campo di Suzdal. Il tifo e gli stenti se n’erano portati via la metà: «Eravamo rimasti in trecento, ci mandarono in un padiglione lungo e basso, isolato dal resto del campo, perché circondato da un altissimo muro». Erano ammassati all’interno, con un’unica finestrella dalla quale entrava una fioca luce. «Il panorama consisteva nelle screpolature del muro che circondava il padiglione e questo era così alto e accostato che non si vedeva il cielo». Nemmeno il cielo. Vedevano però che una parte del muro perimetrale era scheggiata, ogni giorno di più, a delineare la sagoma che pareva essere quella di un uomo. «Era il posto delle fucilazioni».
Nelle giornate, lunghe quanto l’eternità, non si faceva altro che raccontare storie di guerra, avventure amorose o goliardiche, senza dimenticare il cibo, «mangiate e bevute paradossali, il tutto frutto di un’inesauribile fantasia, ma soprattutto della fame, di una fame vecchia, una fame non dico mai saziata, ma neanche leggermente lenita: una fame che mi aveva condotto a pesare meno di cinquanta chili».
In un tale stato di mesta sospensione occupavano il tempo come potevano. C’era chi giocava a carte, «erano in legno, delle dimensioni di un francobollo, e non si tenevano in mano, ma su una specie di leggio e si mescolavano in un sacchetto». Ogni minima novità, poi, era un evento, come quella del 24 dicembre 1943. «Ad un capo del corridoio l’altare era un tavolo coperto con un lenzuolo, sul quale campeggiava una croce fatta con due pezzi di legno legati con lo spago, che avevano in mezzo un santino che rappresentava Gesù crocifisso. In quella atmosfera quasi irreale, così diversa dalla vita semi-animale che avevamo vissuto fino ad allora negli altri campi, fui colto da commozione violenta come tutti gli altri. Poi c’era la clandestinità di quella Messa, la prima che avevamo la ventura di sentire da quando ci avevano catturati, c’era la ricorrenza del Natale, festa magica, tutta famigliare, i ricordi si ammassavano tumultuosi, la nostalgia diveniva dolore pensando a casa, all’angoscia di mia madre che non sapeva che fine avevo fatto».
Passarono altre sofferenze, altri lavori forzati e altri due Natali prima del ritorno a casa. I superstiti, rientrati in Patria dopo anni di prigionia nei campi, feriti nel corpo e nell’animo, sono uomini diversi. Hanno vissuto al fronte le sensazioni più orripilanti, hanno visto le lacerazioni della carne e dell’anima, hanno guardato negli occhi la morte. E il tempo passato in prigionia aveva imposto loro di sopravvivere trattenendo il respiro. Vicentini racconta che quello che è tornato è “un uomo che non è più capace di vere emozioni; nessun disastro, nessuna strage, nessun evento luttuoso lo scuote perché ha un termine di paragone così abnorme che ogni confronto ne esce battuto e questo non solo quando egli non ne è coinvolto. È un uomo tollerante, quasi indifferente”.
Non so se siano diventati cinici o stoici perché nelle parole e negli scritti traspare una grande umanità, non di facciata, frutto di un travaglio interiore, di un viaggio tra le bestialità umane. Sono uomini diversi ma sono anche saggi, franchi, con una giusta dose d’umiltà. Sembrano cioè più colpiti da quelle virtù che vorremmo sempre trovarci attorno. Ecco perché Noi soli vivi, il libro scritto da Vicentini e dal quale sono tratti alcuni dei passaggi in queste pagine, è una testimonianza straordinaria che soprattutto i giovani dovrebbero leggere accanto ai libri di storia.
Matteo Martin
CARLO VICENTINI, classe 1917, è uno dei “Ragazzi di Aosta ’41”. Ha partecipato alla Campagna di Russia con il grado di sottotenente del plotone comando del btg. Alpini sciatori “Monte Cervino” ed è stato insignito di due Medaglie di Bronzo al Valor Militare. Catturato il 19 gennaio 1943, ha passato tre anni in prigionia in diversi campi di concentramento russi, rientrando in Italia nel luglio 1946. Per il suo comportamento in prigionia gli viene attribuito un encomio solenne. Dal 2004 al 2007 è stato presidente nazionale dell’UNIRR. Ha scritto Rapporto sui prigionieri in Russia, Il sacrificio della Julia in Russia e Noi soli vivi.